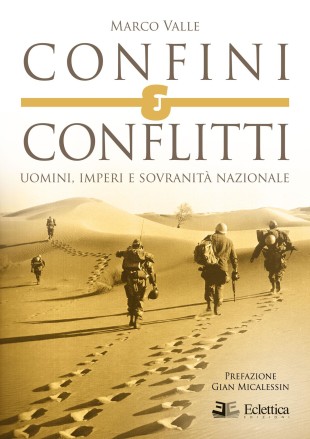(Per gentile concessione dell’editore, pubblichiamo l’introduzione di Gian Micalessin, illustre reporter di guerra, al saggio di Marco Valle, “Confini e conflitti”, Eclettica edizioni)
Per chi come Marco Valle, ed il sottoscritto, è nato a Trieste qualche decennio fa il confine, i Confini, non sono soltanto una demarcazione geografica. Sono una condizione esistenziale. Un margine fisico diventato suggestione mentale e spirituale. Un limite trasformato in voglia di superarlo e superarsi.
Quando devo spiegare perché ho deciso di fare il giornalista, di lasciare la mia città per infilarmi nel cuore di conflitti lontani e dimenticati, racconto spesso di quella frontiera. La chiamavano Cortina di Ferro. Era la fine dell’Occidente, l’inizio di quell’impero ideologico e fisico che da Lubiana arrivava fino a Mosca e Pechino.
Quella frontiera non chiudeva soltanto la nostra città in una morsa fatale stretta tra il mare, l’altipiano carsico e una Jugoslavia diventata la prima propaggine del socialismo reale. Quella frontiera delimitava anche le nostre vite quotidiane segnava le riflessioni dei nostri genitori, determinava le nostre scelte. Ricordo le conversazioni di qualche cena in quei cupi anni 60.
A tavola mio padre, mia madre, ma sicuramente anche quelli di Marco e di tanti altri nostri coetanei commentavano con rassegnata constatazione la nostra condizione di prima linea condannata al sacrificio. “Se scoppia la guerra l’Italia e l’America non ci salveranno. Resteremo dietro le linee. La prima soglia di difesa della Nato passa da Gorizia e poi più in là a Padova. A noi qui nessuno ci difenderà”.
A Roma, a Bruxelles, a Washington nessuno lo aveva mai ammesso. Non era ufficiale. Ma a Trieste si sapeva e basta. Non era certo un caso che i triestini, unici in tutta Italia, facessero il militare a casa propria. Lì in caso di guerra dovevano restare. Lì dovevano venir contattati dalle strutture come Gladio predisposte dalla Nato per dar vita alla resistenza 10 dietro le linee dell’invasore. Ma quello a Trieste a quel tempo ancora non si sapeva né si conosceva. Conoscevamo invece quella frontiera. Ci arrivavamo schiacciati a bordo delle 600 e delle 850 dei nostri genitori, osservavamo timorosi i volti cupi dei graniciari di Tito, spiavamo i kalashnikov affacciati ai finestrini. Venti, trenta muniti di avventura oltre cortina che ad ogni spesa una volta alla settimana facevano battere il cuore accapponare la pelle, sussultar le budella, trasformavano l’abitacolo delle utilitarie di latta in un alveo d’ansia e incertezza.
Eppure si andava. Mamma e papà davanti, le sigarette accese. Noi dietro con le facce appiccicate ai finestrini a scrutar quei mitra quelle divise grigie, quelle facce ombrose, slave e ostili, quelle bandiera e quella stella rossa, quella tristezza disegnata in volti senza sorrisi raccontata da scaffali e vetrine desolatamente vuote. Eppure si andava. Si andava nonostante le nostre paure, nonostante la loro malevolenza. In fondo era solo questione di portafoglio. Di “là” la benzina costava meno. La carne anche. Le sigarette pure. La chiamavano convenienza.
E in quegli anni difficili valeva bene trenta minuti di ansia e paura. Ma in quei trenta minuti inquieti e corrucciati rivivevi anche la storia. Quella più recente. Quella più crudele. Lassù a Basovizza, a tre minuti d’auto dal confine s’apriva la foiba. Ci dicevano solo così “la foiba”. E non aggiungevano altro. Bastava per dipingere nel nostro cuore, nella nostra immaginazione di bambini quel buco nero dell’odio. In quel crepaccio oscuro, erano precipitati amici, parenti, semplici conoscenti dei nostri padri, delle nostre madri, dei nostri nonni. In quell’orrido buio, in quella ferita simbolo della ferocia della nostra terra ciascuna famiglia nascondeva un ricordo, un volto mai tornato.
Erano passati vent’anni. O poco più. Troppo poco per dimenticare. O anche solo perdonare. O ignorare. Eppure quel ricordo, quella frontiera, rimanevano solo nostri. Ad un’ora d’auto o di treno tutto svaniva. Tutto si edulcorava. A Venezia, 11 a Padova, a Milano quella frontiera, quella Cortina di ferro, i carichi di paura ed odio, le memorie di morte e i presagi di nuove guerre sembravano non esistere. Bastava un’ora di viaggio e scoprivi di essere un alieno geografico, il prigioniero d’una frontiera storica e culturale agitata da percezioni che il resto del nostro paese sembrava incapace non solo di condividere, ma persino di cogliere.
Le Foibe cancellate dalla storia non esistevano al di fuori di noi, al di fuori dalla nostra frontiera mentale e geografica. Erano solo una nostra illusione. E anche la paura di quel confine era un’astrazione, una pura rappresentazione locale. L’ansia di quella traballante soglia dell’Occidente, che da un momento all’altro poteva venir sgretolata dai carri di Leonid Breznev sembrava non preoccupare il resto del nostro paese. E questo era forse il confine più impenetrabile. Il confine con un’Italia costruita su un’altra storia, su un altro sentire, su un diverso credere. Un’Italia dai ricordi diversi, dalla memoria estranea. Un’Italia ignara delle nostre ansie di bimbi appena affacciatisi al mondo e delle angosce di famiglie fuggite dal passato travagliato che aveva segnato le storie dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia italiana.
Poi c’era il mare. L’Adriatico delle nostre estati spensierate, dei nostri inverni lunghi, gelidi e cupi. Quel mare era la terza frontiera. Quella in cui affondavano le nostre voglie di fuga, quello su cui galleggiavano i nostri sogni. Le passeggiate di ogni mattina e di ogni sera, lo struscio di ogni domenica terminava sulla cima del molo Audace. Lì erano sbarcati i bersaglieri quando, alla fine della prima guerra mondiale, Trieste aveva alzato il tricolore sui pennoni di Piazza Unità. Lì i bersaglieri erano tornati a correre il 26 ottobre 1954 dopo nove lunghi infiniti anni segnati da dall’odio titino e dall’interminabile odiosa occupazione anglo americana.
Ma oltre quel molo finiva la storia di Trieste, finivano i nostri orizzonti. Finiva la storia perché le vicende di quella città diventata, alla fine, estranea al resto dall’Italia era già stata scordata. La penisola intenta a rincorrere il boom economico e il benessere di Trieste, in 12 fondo non sapeva che farsene. E così sulla cima di quel molo, di fronte a quel mare dilagato intorno ad un territorio striminzito terminava il nostro futuro. Non potevi camminarci sopra, potevi solo sfidarlo. O sognare di oltrepassarlo. Come avevano fatto i nostri nonni e i nostri genitori che da quel molo, a bordo delle navi del Lloyd Triestino, facevano la spola tra New York e Vladivostock, tra Durban e Shangai.
In quegli anni d’infanzia inquieta i loro racconti erano il vento capace di spazzare la risicata realtà geografica del nostro piccolo borgo, di farci sognare, di rincorrere nuovi spazi. Sulle ali di quei racconti superavamo la risicata angustia della nostra terra, delle nostre paure, riconquistavamo il passato ed il futuro diventavamo esploratori, avventurieri e viaggiatori. Da quei racconti dell’infanzia sublimati poi in visioni del mondo nasce questo libro. Un libro dove i confini non sono più limiti, ma suggestioni. Suggestioni per guardare alla storia e scoprirne connessioni sorprendenti, capire che le vicende e le imprese sono sempre disegnate intorno a grandi uomini. E che l’Italia, nella propria insofferente smania auto distruttrice, ha cancellato dalla memoria volti e figure capaci di far impallidire la storia ufficiale.
Quanti nelle nostre scuole o nelle nostre università si son sentiti spiegare che Brazzaville, la capitale del Congo adagiata sul fiume dove navigava il cuore di tenebra di Conrad, prende il nome da Pietro Savorgnan di Brazzà, conte-esploratore d’origine friulana, a cui la Francia affidò la conquista di una parte del suo un impero? Un nobile d’altri tempi capace però di conquistarsi come ci spiega l’autore anche, e soprattutto, il rispetto degli africani. Tanto che, «caso unico nel processo di decolonizzazione, ancor oggi la capitale del Congo ex francese, porta il suo nome: Brazzaville». Ma i capitoli scritti da un Marco Valle, sempre a cavallo tra confini e suggestioni, tra storia e assonanze con il presente, ci portano a rileggere e riscoprire la dimenticata “guerra dello zolfo” scatenata 13 dalla regina Vittoria per garantirsi il monopolio sull’acquisto dello zolfo prodotto dal regno delle due Sicilie. Uno «zolfo (utilizzato per la preparazione della soda artificiale, dell’acido solforico e della polvere da sparo), che copriva il novanta per cento della richiesta mondiale e di cui venti ditte inglesi avevano ottenuto, di fatto, la prerogativa esclusiva, per l’estrazione e lo sfruttamento, grazie al pagamento di un modico compenso».
Uno zolfo puzzolente – ci fa capire Valle come quel petrolio che l’Italia rischia di perdere dopo la guerra a Gheddafi voluta nel 2011 da Parigi e Londra. «Anticipando di un secolo e mezzo gli schemi impiegati negli ultimi decenni dagli anglo-americani in Medio Oriente (e ripreso recentemente da Sarkozy e Cameron in Libia), i ministri della regina Vittoria scatenarono contro il pacifico e debole Stato duosiciliano una violenta campagna di stampa, prodromica all’isolamento internazionale del piccolo regno. La stampa londinese, immediatamente seguita dai suoi terminali europei, enfatizzò gli innegabili ritardi del governo napoletano, il lato pittoresco della dinastia, l’innegabile arretratezza del Paese». Ma l’autore in queste pagine sa accostare il ricordo di Verdi patriota e un po’ reazionario pronto a congratularsi con il generale Bava Beccaris, per aver stabilito l’ordine in una Milano scossa dalla rivoluzione, a quello di un Verdi precursore di una destra sociale ancora di la venire. «Verdi – ricorda Marco – rimase sempre attento alle questioni sociali e civili e un attento osservatore della vita pubblica e non lesinò critiche e interventi soprattutto in ambito locale — fu, nelle liste della Destra post cavouriana, consigliere comunale di Villanova d’Arda e consigliere provinciale di Piacenza — a favore degli umili e dei piccoli proprietari (mal) rappresentati in Parlamento da “grosse vanità e poche teste”.
Leggendo le sue partiture, intrugliate di scritte vergate sui margini, si leggono pensieri veloci, nervosi e sempre più angosciati sulla realtà che lo circonda. “La miseria è molta; è cosa grave e può diventare gravissima, compromettendo anche la sicurezza pubblica. Si tratta di fame!”. “Bisogna trovar del lavoro, e bisogna che i piccoli proprietari non siano troppo aggravati per avere i mezzi di migliorare l’agricoltura, 14 aumentare i prodotti, e dare così del pane alla povera gente”. “Dalla mia finestra vedo tutti i giorni un bastimento, e qualche volta due carichi almeno di mille emigranti ciascuno! Miseria e fame!”».
L’animo inquieto e triestino, l’animo di un Marco Valle che dalla sua scrivania non rinuncia a solcare l’Adriatico e il Mediterraneo ci porta alla guerra d’Algeria. L’occasione è la ristampa di Les Centuriones, il libro dedicato agli ufficiali e ai militari francesi decisi a non arrendersi alle sconfitte d’Indocina e Algeria. «Sguardi profondi, visi abbronzati, corpi atletici avvolti in mimetiche “leopardo”. Marciavano “in quadrato fermissimo” e portavano sul capo uno strano berretto a “coda di rondine”; sul petto medaglie — tante medaglie — e il brevetto. La loro bandiera era un gagliardetto nero con inciso un motto: “Io oso”.
Erano i paràs d’Indocina e Algeria, l’élite delle forze armate transalpine. I “giovani lupi”. Erano belli e crudeli». Il racconto, aperto da quell’estetismo guerresco, ritrova concretezza e solidità nell’analisi con cui l’autore descrive e spiega il fallimento di questa generazione di gladiatori sconfitti dalla concretezza e dalla capacità politica di de Gaulle. «Per di più – scrive Valle – gli ammutinati d’Algeri scontarono la mancanza di leader credibili per una sfida di portata storica. Non a caso il generale Massu, il “papà” dei Paràs, ammise la sua inadeguatezza di fronte al fondatore della V Repubblica: “Io non possiedo la sua cultura, il suo senso politico, la sua necessaria durezza. Non è sufficiente prendere il potere, bisogna essere in grado di esercitarlo”». Ma tra viaggi e suggestioni tra coraggio e confini si svolge l’epopea dei cuori avventurosi che Marco non a caso colloca al termine di queste pagine.
Accostamenti apparentemente incoerenti come quello di Enrico Mattei, il signore del petrolio italiano, e di Jean Schramme, icona, suo malgrado, degli Affreux i mercenari bianchi d’Africa o di Pierre Schoendoerffer, ardimentoso regista francese, al giornalista triestino Almerigo Grilz. Eppure a leggerle quelle storie hanno 15 tanto, troppo in comune. Se Mattei rincorre il sogno impossibile di contrapporsi alle “sette sorelle” per regalare l’indipendenza energetica al proprio paese, Schramme tenta anacronisticamente di ridisegnare un’Africa fatta di collaborazione tra bianchi e neri, un’Africa liberata dall’ideologia e scevra dall’influenza delle grandi potenze e dei loro interessi economici. Scompariranno entrambi al termine di un viaggio. Un viaggio in aereo segnato da uno schianto, Mattei. Un viaggio segnato dall’oblio, Schramme. E come non scorgere le analogie tra Pierre Schoendoerffer e Almerigo Grilz.
Nell’oblio riservato dalla cultura ufficiale francese ad un Pierre Schoendoerffer colpevole di non aver marciato a sinistra c’è tanto dell’ oscurità che il giornalismo italiano ha calato sulla memoria di Almerigo, il cuore nero triestino fuggito dai confini della sua città per riposare sotto un grande albero in terra di Mozambico.
*”Confini e conflitti” di Marco Valle, Eclettica edizioni (per ordinare il volume basta scrivere ad info@ecletticaedizioni.com oppure telefonare allo 0585-254409)